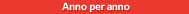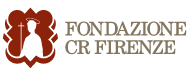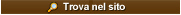di Pierangelo Gentile (Università di Torino)
[Le parole evidenziate nel testo rinviano a link esterni elencati in fondo alla pagina]

Stampa d’epoca con il monumento fiorentino a Vittorio Emanuele II di Emilio Zocchi, inaugurata in piazza della Repubblica (allora Vittorio Emanuele) il 20 settembre 1890. La statua equestre fu riposizionata nel 1932 in piazza Vittorio Veneto.
Lo spostamento della capitale da Torino a Firenze stabilito dalla Convenzione di settembre del 1864 siglata tra Italia e Francia non fece altro che fomentare il “piemontesismo”, sentimento antinazionale che caratterizzava agli occhi degli italiani il suddito sabaudo, legato alle virtù civiche e militari, alla dinastia, alla tradizione dei costumi, alla fede cattolica, allo stile di vita morigerato del vecchio regno di Sardegna. Un sentimento forte e diffuso anche nei salotti torinesi più altolocati. A casa della contessa di Sambuy, ad esempio, si udiva frequentemente il ritornello «l’Italia stia a casa sua. Noi, nel nostro piccolo Piemonte, stavamo così bene senza questi fratelli d’un altro letto»; anche presso l’abitazione degli Sclopis di Salerano, ricorreva spesso la deprecatio temporum del vecchio conte Federigo, presidente del Senato, convinto che gli antenati avessero ragione «quando si vantavano quasi di non essere italiani, e volevano essere considerati come una stirpe media tra italiana e francese». A questi fieri e aristocratici sostenitori del piemontesismo si affiancarono anche altri torinesi i cui interessi dipendevano dal primato della città capitale: i commercianti e i bottegai, terrorizzati dalla diminuzione dei guadagni causata dal trasferimento della corte, del governo, del parlamento; i numerosi impiegati dei ministeri e i piccoli funzionari preoccupati per i disagi e gli oneri finanziari che imponeva il graduale spostamento degli uffici a Firenze stabilito dalla diplomazia; i veterani alle prese con le difficoltà di reinserimento nella vita civile. Insomma, da un lato la tradizione e dall’altra il tornaconto.
Ma il piemontesismo era anche sentimento fatto di delusione e perplessità da parte di certa classe politica e di certa borghesia che rivendicava al vecchio Piemonte il ruolo leader nel processo di unificazione. Questa miscela di affetti e passioni diede fuoco alle polveri della violenta protesta, che a Torino sfociò in un vero e proprio bagno di sangue nelle giornate del 21 e 22 settembre 1864 appena si era diffusa la notizia della firma della ‘Convenzione di settembre’ e soprattutto delle conseguenze dell’allegato ‘segreto’. La folla aveva invaso piazza Castello e piazza San Carlo, e il contingente militare chiamato a contenere la manifestazione, per la confusione degli ordini, provocò la tragedia con scariche di fucile e assalti alla baionetta. Risultato: 52 morti e 159 feriti. A questa strage fece eco, dopo altre piccole esplosioni di malcontento che incrinarono il rapporto strettissimo e secolare della città con la dinastia, la protesta contro la corte il 30 gennaio 1865.

Targa commemorativa della strage di Torino del settembre 1864, allocata dall’amministrazione comunale torinese in piazza San Carlo nel 1999.
Quel giorno avrebbe dovuto svolgersi a Palazzo Reale il tradizionale primo ballo dell’anno. Ma all’insegna dello slogan Reggia da vendere – padrone da appendere, la festa si trasformò nel triste epilogo dei fasti della corte sabauda a Torino. Non furono sufficienti i rinforzi di truppa in piazza Castello per proteggere gli invitati che entravano nella reggia. La folla si era riunita a ridosso del cancello palagiano, e quando principiò lo sfilare delle carrozze alcuni fischi e grida di protesta si fecero sentire, crescendo a poco a poco d’intensità. Furono lanciati sassi contro i vetri delle vetture, senza che la Guardia nazionale si desse pensiero di trattenere i manifestanti, di chiuder loro il passaggio o di far cessare lo scandalo; anzi nel momento in cui le cose minacciavano di farsi più gravi, avendo un ufficiale comandato ai suoi soldati di farsi avanti, questi rimasero fermi con la baionetta in canna.
Intanto, ai primi schiamazzi il re si era affacciato a una delle finestre della reggia per capire cosa stesse succedendo. Si udivano le urla, i fischi, si vedeva il brulichio della folla; ma ciò che agli occhi del monarca era ancora più sconveniente della dimostrazione di piazza era il gran vuoto delle sale; molti invitati s’erano astenuti dal presentarsi, molte signore, impensierite dalla mobilitazione dell’esercito, già vestite per il ballo, erano rimaste in casa; altre erano tornate indietro a mezza strada, e così i presenti nel salone degli Svizzeri si contavano sulle dita; erano vuoti perfino i banchi riservati ai cavalieri dell’Annunziata.
L’addio si consumò con il risentimento della città nei confronti del suo re. Vittorio Emanuele, il giorno seguente, profondamente offeso dall’atto “vergognoso” di protesta, con aria di sfida usciva in vettura scoperta dal suo palazzo, accompagnato dal solo presidente del Consiglio, Alfonso La Marmora. Senza scorta, transitando per via Po, si trasferiva al castello di Moncalieri, lasciando i torinesi mortificati della lezione loro inflitta.
Poi l’annuncio laconico della “Gazzetta Ufficiale” del 3 febbraio 1865: «Questa mattina alle ore 8, Sua Maestà il Re è partito da Torino per Firenze, accompagnato da Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio dei ministri, generale La Marmora».

Alfonso La Marmora, il primo presidente del consiglio di Firenze capitale. Varato il suo primo governo il 28 settembre 1864, rimase in carica fino al 20 giugno 1866.
Dopo 302 anni era il tramonto definitivo dell’antica corte sabauda. Il destino beffardo aveva voluto che il primo re d’Italia lasciasse Torino lo stesso giorno in cui Emanuele Filiberto, l’eroe di San Quintino, al braccio della consorte Margherita di Valois, il 3 febbraio 1563, era entrato solennemente nella nuova capitale del ducato sabaudo. Transitando per Piacenza e Bologna, e poi sulla ferrovia Porrettana da poco inaugurata, Vittorio Emanuele II giunse alla stazione di Firenze alle dieci e mezza di sera, accompagnato oltreché da La Marmora, dal ministro dell’istruzione barone Natoli, e da quasi tutti i componenti delle sue case civili e militari.
Secondo la cronaca del giornalista Ugo Pesci, l’«orribile» stazione di Firenze fu sfarzosamente illuminata e addobbata per ricevere degnamente il regale ospite. Tutti i senatori e i deputati della ‘nuova capitale’, le autorità civili, militari e municipali, oltre a moltissimi dei più ragguardevoli cittadini, per ore si erano assiepati sulla banchina del binario per attendere frementi l’arrivo del sovrano. E Vittorio Emanuele «fu gradevolmente sorpreso e commosso della affettuosa accoglienza che, specie a quell’ora, non si aspettava». Per manifestare più eloquentemente i suoi sentimenti, «con insolita effusione», in un raro slancio di tenerezza, il “re soldato” abbracciò «il più onorando fra i presenti […], il vecchio e cieco senatore Gino Capponi». Poi cominciò il tripudio nelle strade di Firenze; le entusiastiche acclamazioni della folla; la scenografia sfarzosa con le vie che conducevano dalla stazione a Palazzo Pitti – «alcune delle quali molto anguste» – illuminate, imbandierate e gremite di popolo festante; le legioni della Guardia nazionale schierate in pompa magna a fare ala al corteo. E in via Tornabuoni era tale la ressa, che la carrozza reale dovette procedere a rilento, circondata poi dai soci del Club dell’Unione e del Casino Borghese – «vale a dire dai rappresentanti della nobiltà e della migliore borghesia» – che, «torcetti di cera» in mano, fecero strada al monarca verso la sua nuova residenza alle pendici della collina di Montecucco. Giunto alla reggia, Vittorio Emanuele, a causa delle «insistenti acclamazioni del popolo», fu obbligato più volte ad affacciarsi dal balcone. E «la mezzanotte era già suonata da un pezzo, quando tacquero i festosi rumori di quella spontanea e affettuosa accoglienza».
Nei giorni seguenti il re non seppe resistere alla tentazione di andare a caccia nella tenuta di San Rossore. Poi giunse a Firenze la delegazione dell’amministrazione torinese incaricata di chiedere scusa a Vittorio Emanuele per l’atteggiamento che aveva provocato il movimentato “addio”. Così ricomposto, l’antico legame tra Casa Savoia e la città subalpina era salvo. Ma una nuova fase della storia d’Italia e della dinastia del Biancamano aveva già avuto inizio sulle rive dell’Arno.
Bibliografia di riferimento
- U. Levra, Settembre 1864: centocinquant’anni, «Studi piemontesi», XLIII (2014), n. 2, pp. 285-309
- P. Gentile, L’ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte, Torino-Roma, Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano-Carocci, 2011
- P. Gentile, L’immagine del re e della corte, in 1860-1861: Torino, Italia, Europa, a cura di W. Barberis, Torino, Archivio storico della Città di Torino, 2010, pp. 77-103
- R. Roccia, Emanuele Luserna di Rorà, sindaco di Torino: i giorni della «diniegata giustizia», in Prove di Risorgimento su uno scenario europeo. Emanuele Luserna di Rorà, la famiglia e il suo tempo da Bene Vagienna a Torino all’Italia, a cura di A. Malerba, R. Sandri Giachino, G. Mola Di Nomaglio, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2008, pp. 77-130
- U. Pesci, Firenze Capitale (1865-1870) dagli appunti di un ex-cronista, Firenze, R. Bemporad & figlio, 1904
Elenco dei link in ordine di citazione (il loro funzionamento è stato verificato il 20 gennaio 2015)
- Convenzione di settembre:
- Federigo Sclopis:
- Guardia Nazionale (Francia e Italia)
- Vittorio Emanuele II – Re d’Italia
- Alfonso Ferrero di La Marmora
- Emanuele Filiberto – Duca di Savoia
- Ferrovia Porrettana
- Palazzo Pitti – Firenze
- Umberto di Biancamano
- Dinastia Savoia – origini e rami familiari