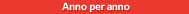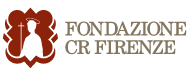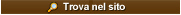Immagine di copertina:
Immagine di copertina:di Marino Biondi (Università di Firenze)
Vasco Pratolini è giunto a lambire la soglia del suo centenario. Ha un cuore antico come la città. E la sua città lo ricorderà con un convegno nazionale che si svolgerà a metà ottobre. Ma se ne ricorderà Firenze, quella sua, quella vera? Quella che non va ai convegni, non sale le scale di Palazzo Vecchio, e non legge la critica letteraria? Non lo sappiamo, ma lo speriamo. Vasco è stato il cantore di tutti i fiorentini, nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte, per evocare la formula di un patto sacro con la propria terra, che era poi terra urbana, la città come luogo per eccellenza della comunità, dell’agire comune, o dell’aspro contendere sulle idee e sui poteri, l’intra moenia delle coscienze unite o divise. Nato a Firenze, in via dei Magazzini, il 19 ottobre 1913, da Ugo e Nella Casati, da un padre cameriere e da una sarta, che lo avrebbe lasciato orfano nel luglio 1918, con un carico di tristezza mai dileguatasi fino in fondo, la nonna Rosa di origine contadina, il popolo nel sangue, il celebre scrittore si è spento nella sua casa di Roma la mattina del 12 gennaio 1991. Riposa, come da suo desiderio, alle Porte Sante di San Miniato, accanto a Ottone Rosai, artista e maestro. Quando morì, era già un classico della modernità letteraria. Come molti scrittori, era cresciuto senza scuole regolari, con molte ore rubate al sonno, fra un lavoro e l’altro, operaio tipografo e utente della Biblioteca Nazionale, leggendo altra letteratura, per omeopatia, da Dante a Collodi, da Jack London a Dostoevskij. Pratolini fu scrittore coltissimo ma non lo diede a vedere. Apparve dapprima semplice e poi inutilmente complicato. La critica ebbe molti debiti con lui e la sua arte. Sembrò, in quel suo crepuscolo dei primi anni Novanta, incrociare il presente da estraneo, come se provenisse da postazioni remote, lungo la direttrice della storia italiana che era stato lui stesso a raccontare nel Metello e nella trilogia, dalla fine dell’Ottocento, con l’inizio delle lotte operaie, in una Firenze anarchica e borghese, fino al Novecento totalitario, in una porzione del quale era stato coinvolto per ingenuità e passione, abbattuto anche da una guerra di liberazione, a cui aveva preso parte con convinzione e orgoglio, ma ormai lontano da Firenze. Nella Roma della sua seconda vita.
La sua fama non è rimasta intatta. È stata scalfita da vari fattori, anche le rocce vengono erose dal vento. E il vento sono state le mode letterarie, che già con l’avanguardia del Gruppo 63 avevano cominciato a diffamare ed emarginare i narratori classici come Pratolini, Cassola, Bassani, Piovene, per far posto ai funamboli della prosa senza storie né personaggi, e agli astuti scalatori del potere editoriale e precoci tecnici dei media. Si potrebbe dire, e non sarebbe neppure un paradosso, che Vasco Pratolini fu soltanto un grande narratore, sulla via maestra dei narratori, da Boccaccio e dai novellieri della tradizione toscana, che comprendeva anche i cronisti e gli storici, ma in quell’Italia che si avviava a fare piazza pulita anche della tradizione del racconto, inneggiando alla sola virtù del nuovo senza memoria, quella grandezza quasi istintiva non sarebbe più bastata. Nessuno ha raccontato Firenze come lui, facendo di Firenze, pur raccontata le mille volte, la sua Firenze, una città con segno pratoliniano, come è esistita una Parigi proustiana. La città pratoliniana è stata quella dei poveri amanti e quella dei duellanti che contendono fra loro nell’infinito conflitto delle avverse parti politiche. Il rosso e il nero. I grandi scrittori lasciano impronte indelebili sulla terra, da cui hanno tratto vigore e ispirazione. E tutta la letteratura pratoliniana è in Firenze, fra le sue mura, un luogo che poi diviene il mondo, ma è il mondo in cui scorre quel sangue, quel miele, quel fiele, quell’aria, quella dolcezza tenera e crudele. Narratore di storie, e di che altro se no? Storie molto umane, di ragazzi e ragazze, di giochi adolescenziali, di amori nascenti, ma anche di virtù ed energie virili precocemente maturate al fuoco dell’esperienza. Che in lui era fatica, lavoro, crescita, evoluzione umana, nei travagli ma anche nelle felicità che ci sono concesse. Un narratore che profondamente sentiva la femmineità, pur senza esibizioni di eros, in ogni età dell’esistenza, dalla bellezza giovane alla violenta maschera della tarda senilità capricciosa e arrogante (la Signora di Cronache) alla donna come Ninì, sfregiata dalla sua stessa inappagata ansia di vivere. Le sue donne, di cui ci lasciò una galleria memorabile, donne che prima di essere tali, erano state le sue vergini sognanti l’amore e la vita, quella che sarebbe stata quando ne sarebbe venuta l’ora. I quartieri, le case, le povere case, l’odor della cena, dei letti disfatti al mattino, l’eros umile e potente delle sue coppie, amorose eppure caste, i lungarni sotto la luna, il passare del tempo e delle stagioni. La malia di Firenze. Ma un paesaggio quello pratoliniano tutto e solo umano, civilizzato, mai una natura contemplata in sé, distinta dall’uomo e dalle sue opere. Un laico senza alcun tremore di metafisica, tutto e solo impregnato di storia.
In un’intervista rilasciata qualche mese fa, dopo avere compiuto i novant’anni, Franco Zeffirelli, riandando alla sua vita avventurosa, aveva espresso il desiderio che ci fosse stato un Pratolini a raccontarla, e allora sarebbe stata non solo vita ma romanzo. Quanti di noi, pur senza avere vite grandiose, ma ugualmente potrebbero dire lo stesso, intuendo in lui il mago delle storie. Eppure il suo astro sta solcando da qualche decennio un’orbita secondaria nel firmamento delle nostre lettere. Anche l’obsolescenza di alcune tematiche storiografiche e delle grandi contrapposte ideologie (fascismo-comunismo) ha contribuito all’eclissarsi della centralità di autori fortemente politicizzati, come lui era stato. Dunque il venir meno delle passioni politiche, nell’enfasi di una sacralizzazione della politica, e lo stingersi degli antagonismi feroci e vivissimi a quelle passioni legati, ha condizionato la piena e persistente attualità di opere come Cronache di poveri amanti (1947) e Lo scialo (1960-1976), il cui pilastro storico è stato il fascismo negli anni del suo primo potere (1925-1926), e in quelli della lenta deriva di corruzione. L’opacità del tempo ha avvolto le pagine dei suoi primi racconti (Il tappeto verde, Via de’ Magazzini, Diario sentimentale) e quelle più ardue e quasi ostili dei suoi ultimi romanzi (Lo scialo, Allegoria e Derisione). Ma è rimasto limpido il suo profilo di grande narratore popolare, istintivo affabulatore di un luogo fecondissimo di storie seriali come Firenze. Pratolini è stato il cronista della vita minuta tra i quartieri, l’epico poeta di via del Corno, il biografo romanzesco di Metello Salani, lo storico del fascio fiorentino, violento e insanguinato, l’autobiografo dell’intellettuale politico, tra fascismo e comunismo, nel corso del Novecento. A lui, dai racconti di Via de’ Magazzini alle prose e ai versi del Mannello di Natascia, la città resterà legata nel tempo. Se c’è stato uno scrittore di Firenze e per Firenze, non può che essere stato Vasco, il cronista e lo storico di una comunità millenaria, unita e divisa, miele e fiele, la città di cui si prese carico fin dalle sue prime giornate memorabili di adolescente in Santa Croce. La città prima fu vissuta, poi divenne oggetto perpetuo di riflessione narrativa. Vide Firenze, e l’amò, dalla fine degli anni Trenta sempre da lontano. Solo così ha potuto ricrearla nella memoria e nell’arte. Una ricreazione che è passata attraverso un’indagine prima di scrittura lirica, lieve e poetizzante, e poi di vera storia, trasfusa nella trilogia dei romanzi di storia italiana. Dalle cronache, come quelle degli antichi cronisti della sua città, è passato alle storie. Lo scialo è stata l’opera definitiva, vastissimo e potente ordito romanzesco. Seguì Allegoria e Derisione, romanzo versato in una scrittura allusiva, ermetica, che perdura fino alla fine, anche nei versi e nelle prose del Mannello di Natascia (1985). La memoria vi appare impegnata a sciogliere nodi, matasse, sempre controversa e litigiosa anche con se stessa. La storia non veniva abbandonata, e neppure il fascismo originario, ma entrambi ripresi in altre modalità narrative. Il rendersi conto del passato, di tutto il passato, nell’ossessione dell’integrità del ricordo, fu la sfida del romanziere storico. Come fu che accadde e in quel modo? In un crocevia lontano, e oscuro, un labirinto di idee, ideali, illusioni, cocenti e tragici addii, un punto cieco che il romanzo, quella specie di romanzo o antiromanzo che era diventato Allegoria e Derisione, lasciò in eredità come l’ultima delle sue opere.
Cronache di poveri amanti, scritte a Napoli, e Lo scialo, dei cui tempi di scrittura e riscrittura, in un arco di tempo che va dai Cinquanta fino al 1976, sappiamo dai carteggi (con Alessandro Parronchi e Romano Bilenchi), indagarono la stessa realtà storico-politica, da posizioni diverse e opposte, il fascismo visto e giudicato come il male politico e umano dall’antifascismo (del popolo), al fascismo vissuto colpevolmente ma con complici intimità condiviso dalla borghesia cittadina. Dal manicheismo elementare di Cronache, in cui il bene politico trionfava nel martirio della militanza (Maciste), dove si sanno spartire con sicurezza il bene e il male, e al popolo era dato proteggere il suo cuore innocente, alla viziosa immagine di una corruttela che contagia e s’espande fino alla fine delle storie. Lo scialo non dà scampo alla borghesia fascista. Il Quartiere fu scritto a Fermo, fra aprile e luglio 1943, portato a termine a Roma nei giorni della Resistenza, che imprime la sua impronta nel finale del romanzo. Le Cronache fin dalla prima intuizione apparvero a Napoli, una città che avrebbe potuto ispirargli altre cronache, ma rimase distante da quel tasso di natività, indispensabile all’alchimia della narrazione. Pratolini narra, almeno fino a un certo punto della sua storia di scrittore, solo se riesce a pervenire a una fusione calda, se avverte e conserva la trama delle affinità, la simpatia umana, l’empatia con i personaggi. E così per gli altri romanzi, portati in giro nelle fasi di stesura e conclusione fra Procida Capri e Roma. Ma alla città, dove era vissuto fino al 1939, Pratolini era rimasto avvinto come alla sorgente prima e insostituibile della scrittura narrativa, e infine alla città che, profondamente mutata, negli anni Sessanta e oltre aveva alimentato una ribellione sorda e profonda che era esplosa anche in forme di lotta armata. Tutto era nato da lei, da Firenze, dalla sua normalità, dalle sue patologie, dal suo stilnovismo come dal suo becerismo e dalla sua crudeltà, da quella cuna di mondo, fra strade strette, malsane, ma sempre con nomi su cui gravitava la storia (via de’ Malcontenti, Borgo Allegri), uscio a uscio, piazze storiche (Santa Croce), quartieri (via dell’Ulivo, il quartiere posto al limite del centro della città), fra piccole consorterie innocenti o ribalde (i crociati, ragazzi di strada che nulla hanno da spartire con l’acquario in cui trascorre l’infanzia del fratello Dante / Ferruccio, il deuteragonista di Cronaca familiare), fra poveri amanti, amanti cioè che erano poveri e si amavano di un amore ora quieto e fedele ora febbrile e malato. Gli affetti in quei paraggi, si legge nel Quartiere, erano «difesi con i denti.» Senza di quelli, la povertà sarebbe diventata disperazione. E alla pagina seguente: «Eravamo creature comuni. Ci bastava un gesto per sollevarci collera e amore.» L’amore fu il perno delle azioni romanzesche, fino a quando restavano in una cerchia di antichi affetti, infranti i quali scemava l’amore come la collera, e si adagiava sul fondo un torbido sentimento di indifferenza. Poche le eccezioni, il Ponte Milvio a Roma, la Resistenza, la guerriglia antitedesca («gli assurdi guerriglieri, il cui successo, entro il cerchio di una leggenda paesana, consisté tutto nel riuscire a mantenere il mistero, l’incubo della loro sterminata, silenziosa presenza»), la rinascita, dopo un torvo epilogo nel fascismo morente: «Ma anche la solidarietà ci fu, esplicita, dei poveri e di chi, in quei giorni, volle meritare se stesso e il proprio cuore.» Meritare se stesso, come si legge in Il mio cuore a Ponte Milvio, è frase pregna di significato autobiografico, decisivo per l’uomo Pratolini. In quelle pagine, lontano da Firenze e da un’altra stagione della sua vita (e passione politica), lo scrittore ebbe a ritrovare un popolo (alla macchia), silenzioso, agile, taciturno, in cui poté riconoscersi e ritrovarsi. Le pagine sul Ponte Milvio o Ponte Mollo sono state la sua personale, oltre che politica, liberazione, e segnarono il passaggio a un’altra vita. Perché dopo la prima vita, una seconda vita andava riconquistata sul campo, e pertanto rimeritata. Pratolini ha sempre dovuto meritarsi la vita, a ogni momento: «Così io riscattai la mia infanzia», lo aveva scritto già in Prima età, un frammento de Il tappeto verde.
Come citare questo articolo: Marino Biondi, Ottobre 2013: Pratolini ha cent’anni, in "Portale Storia di Firenze", Ottobre 2013, https://www.storiadifirenze.org/?temadelmese=ottobre-2013-pratolini-ha-centanni